Contratto di sviluppo semiconduttori: stabiliti i termini e le...
Il Ministero delle imprese e del Made in Italy ha pubblicato il decreto direttoriale che definisc...

Horizon Europe si presenta oggi come il più ambizioso programma di ricerca e innovazione che sia mai stato realizzato dall’Unione Europea.
Fondato sull’esperienza del precedente programma “Horizon 2020”, dopo aver raggiunto l’intesa nel dicembre 2020, ne sono state implementate le misure di sostegno dedicate alla ricerca e all’innovazione, grazie ad una dote finanziaria di quasi 100 miliardi da adoperarsi tra 2021–2027.
Esso dovrebbe costituire uno degli strumenti chiave per guidare il recupero degli Stati europei nei prossimi anni, che dovrà necessariamente evolversi in termini di preparazione e resilienza.
Una delle principali novità del programma è l’approccio basato su alcuni obiettivi che l’Unione Europea chiama mission. Le missioni europee di ricerca e innovazione sono state concepite per fornire soluzioni ad alcune delle più grandi sfide del tempo attuale: cancro, cambiamenti climatici, salute degli oceani ed altro ancora.
Ogni missione si prefigge di risolvere una sfida pressante della società includendo un portafoglio di azioni, interventi, policy, che dovranno essere implementati nei prossimi anni con la consapevolezza di dover raggiungere traguardi rilevanti per la società.
Per garantire un buon monitoraggio dei risultati e delle criticità, verranno inoltre previsti, all’interno del settennio, piani minori e di controllo come il Piano Strategico 2021-2024 che definisce l’indirizzo politico, i macro orientamenti strategici e gli impatti attesi nel primo periodo di applicazione del programma e le call per i primi 4 anni.

L’attuazione del programma trae fondamento da 3 pilastri, ognuno dei quali caratterizzato da una propria dote finanziaria:
all’interno di questo primo pilastro si svilupperanno i progetti del Consiglio Europeo della Ricerca (CER), le azioni Marie Curie volte a stimolare:
Il secondo pilastro si concentra, invece, sulla ricerca di soluzioni che rispondano alle sfide globali, permettendo agli enti partecipanti non solo di dare un vero contributo al benessere mondiale ma anche di sviluppare una maggiore competitività industriale.
Vengono individuati in questo senso sei cluster tematici su cui gli investimenti e le attività di ricerca dovrebbero focalizzarsi maggiormente:
Il terso ed ultimo argomento su cui si focalizza il programma è l’innovazione europea. Nel 2019, infatti, indicativo dell’importanza che questo tema avrebbe avuto nella rinascita dell’Europa, si è inserito nel contesto comunitario il Consiglio Europeo per l’Innovazione (dall’inglese European Innovation Council – EIC), destinato a divenire il promotore dei primi interventi “Horizon Europe” oggi conosciuti.
Questo organo centralizzato si prefigge di sostenere le tecnologie promettenti a forte potenziale attraverso tre fasi pilota caratterizzate da sovvenzioni flessibili e finanziamenti rilasciati gradualmente nel tempo: dalla Ricerca e Sviluppo sui fondamenti scientifici delle tecnologie (EIC Pathfinder), alla convalida e dimostrazione degli stessi (EIC Transition), fino alla fase di ingresso di queste tecnologie sul mercato (EIC Accelerator).
Con la stesura del programma, la Commissione ha deciso di inserire il Consiglio Europeo per l’Innovazione, l’ecosistema europeo dell’innovazione e lo European Institute of Innovation and Technology (EIT), nel terzo pilastro, con l’obiettivo di rafforzare la leadership europea nel campo delle tecnologie di punta e delle innovazioni dirompenti, nonché il loro impatto sullo stile di vita europeo e sul benessere dei cittadini.
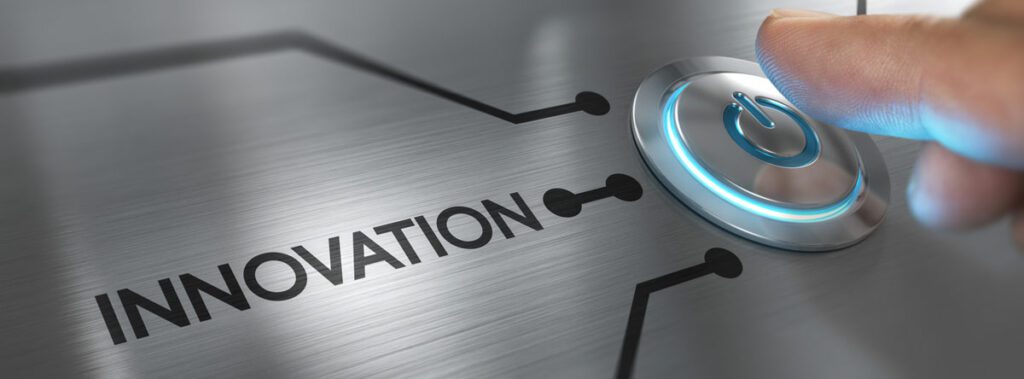
Le mission previste dall’Unione avrebbero potuto destare non poche preoccupazioni se non fossero state supportate da un buon impianto strutturale: il Consiglio infatti, da solo, non avrebbe potuto rispondere a tutte le necessità del settore innovativo a causa della grande complessità che lo caratterizza. Sorta la necessità, quindi, di porre delle fondamenta più solide, al Consiglio è stato affiancato un altro importante organo: l’Istituto europeo di Innovazione e Tecnologia, esistente dal 2008, migliorato e strutturato per poter rafforzare la capacità europea di innovare costantemente.
Se da un lato è palese che l’innovazione sia un tema veramente scottante, occorre però ricordare che non è il solo pilastro attivo: diverse possibilità sono state annunciate recentemente in tema di “eccellenza scientifica” soprattutto nel campo delle Azioni Marie Sklodowska Curie dedicate alla formazione e alle reti di dottorato.
L’Unione Europea punta davvero in alto con questo programma ma dovrà comunque confrontarsi con le aspettative molto elevate che il mercato ha sviluppato e sta ancora sviluppando a causa del periodo pandemico. Unica certezza è che questa tipologia di finanziamenti servirà ad affrontare le minacce incombenti nel breve e nel medio periodo e, allo stesso tempo, a prepararsi per il futuro.
I nostri articoli
Vedi altro arrow_forward
Il Ministero delle imprese e del Made in Italy ha pubblicato il decreto direttoriale che definisc...

Con il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 è cambiata la disciplina in materia di Whistle...

La Carbon Neutrality, come definita nella recente normativa ISO 14068-1:2023, emerge come un trag...

Nella tarda serata di venerdì 29 marzo 2024 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decret...